Un nuovo progetto editoriale dedicato alla vita e alla carriera di Vasco Rossi sta per arrivare in libreria e fumetteria. Dal 19 maggio debutta infatti Vasco – La Rabbia Giovane, primo capitolo della serie “Vasco. Una favola lunga una vita”, la graphic novel realizzata da Sergio Bonelli Editore (realtà alla quale sono affettivamente legato perchè ho collaborato con loro in passato) che racconta in tre volumi la storia del celebre rocker italiano.
L’iniziativa segna una nuova collaborazione tra l’editore milanese e uno degli artisti più amati della musica italiana, dopo il successo del precedente progetto che aveva incrociato l’universo di Dylan Dog con le canzoni del Komandante.
La graphic novel dedicata al rocker di Zocca
Il primo volume della trilogia, Vasco – La Rabbia Giovane, sarà disponibile dal 19 maggio e inaugura una collana pensata per raccontare in forma di fumetto il percorso umano e artistico del cantante. Il progetto editoriale è strutturato in tre volumi a colori da circa 100 pagine ciascuno, che ripercorrono momenti chiave della vita di Vasco: dagli inizi fino alla consacrazione come icona della musica italiana. Attraverso il linguaggio della graphic novel, la storia del rocker di Zocca prende forma in una narrazione intensa e visiva che intreccia musica, memoria collettiva, Episodi biografici e immagini evocative. Il risultato? Un racconto capace di restituire il ritratto di un artista che ha influenzato più generazioni di ascoltatori.
Gli autori: Barbara Baraldi, Sergio Gerasi e Flavia Biondi
Alla sceneggiatura della trilogia troviamo Barbara Baraldi, scrittrice e curatrice di Dylan Dog, già autrice dell’albo speciale Dylan Dog: Jenny, ispirato alla celebre canzone "Jenny" di Vasco Rossi. I disegni sono invece affidati a due artisti di grande rilievo nel panorama fumettistico contemporaneo: Sergio Gerasi e Flavia Biondi I due illustratori interpretano il protagonista con stili differenti ma complementari, offrendo una rappresentazione visiva capace di raccontare le molte sfaccettature della personalità di Vasco.
Contenuti extra e materiali d’archivio
Ogni volume della serie includerà anche una sezione speciale con contenuti aggiuntivi, pensati per arricchire la lettura e offrire un contesto più ampio alla narrazione. Tra i materiali presenti: documenti d’archivio, testi autografi, fotografie storiche e approfondimenti legati alla carriera del cantautore. Tutti elementi in grado di dialogare con la storia illustrata, contribuendo a costruire un racconto ancora più completo del percorso artistico del rocker.
Fumetto e musica: il progetto editoriale Bonelli sul Blasco
Con “Vasco. Una favola lunga una vita”, Sergio Bonelli Editore continua a esplorare il rapporto tra fumetto e cultura popolare, utilizzando il linguaggio della graphic novel per raccontare grandi icone italiane. Il primo volume uscirà il 19 maggio, mentre i successivi capitoli della trilogia arriveranno:
-
a luglio, con il secondo volume
-
in autunno, con la conclusione della trilogia
Un progetto editoriale che unisce fumetto, musica e memoria generazionale, celebrando la storia di uno degli artisti più influenti ed amati della musica italiana.
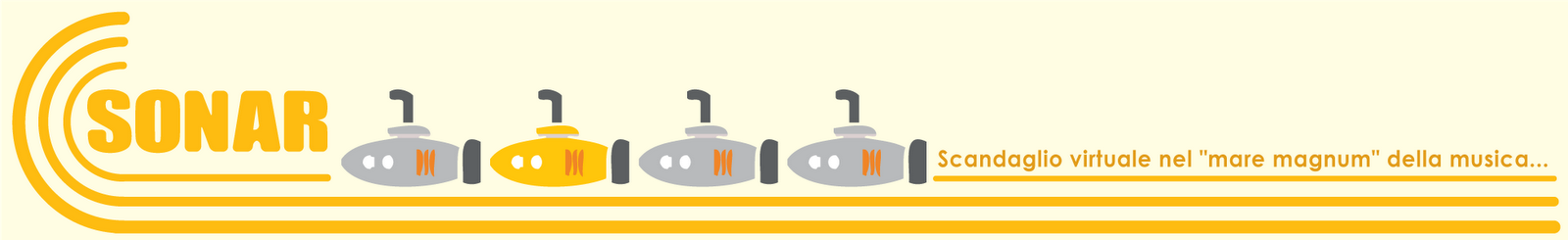


























.jpg)





